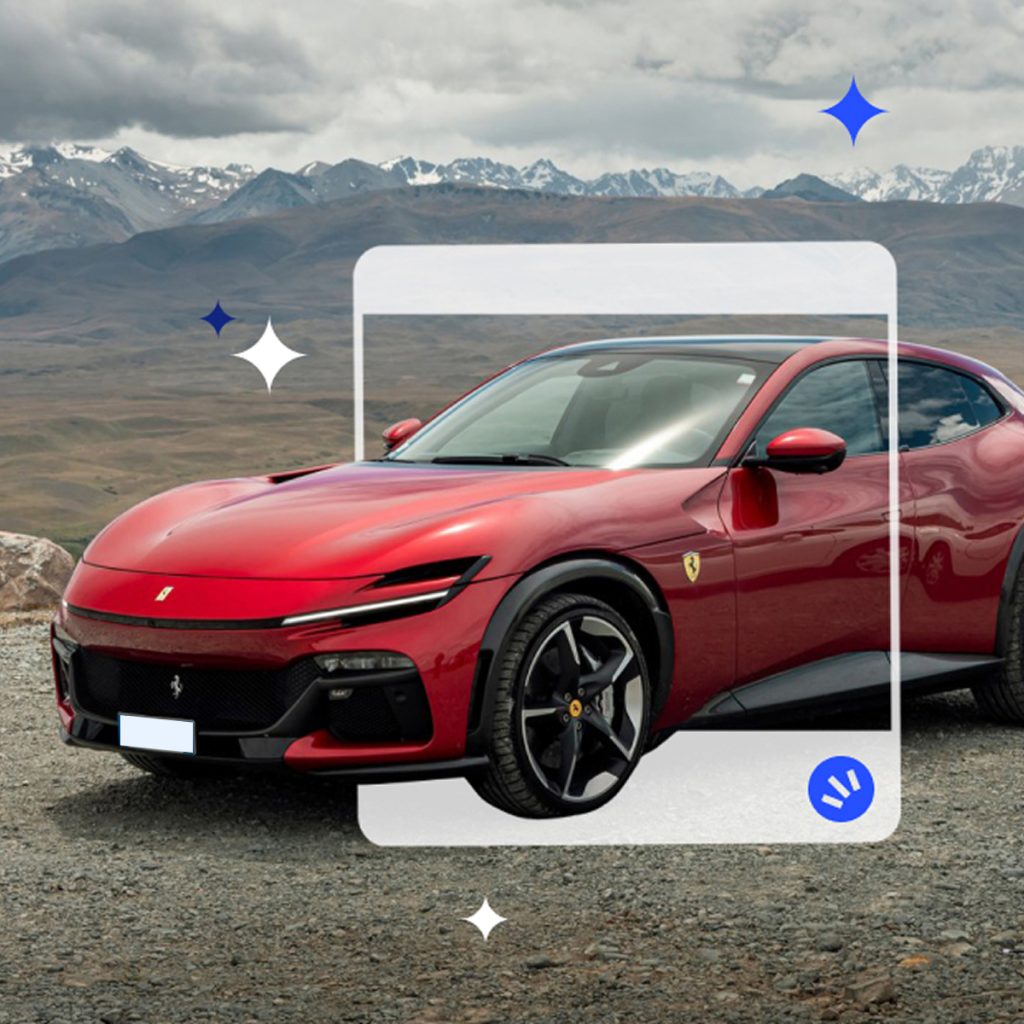Cohousing: la guida completa
Coabitare può essere la soluzione vincente
La condivisione di spazi accessori può accentuare il senso di comunità e fornire soluzioni concrete al disagio sociale, garantendo comunque ai singoli l’esclusiva delle proprie abitazioni: il cohousing traduce in termini di progettazione partecipata l’esigenza di migliorare la qualità di vita per tutte le fasce di età, in un contesto solidale e sostenibile.
Cos’è e come funziona il cohousing?
Nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli, la frammentazione dell’abitato produce una serie di ricadute:
- le persone perdono i contatti con il vicinato, richiudendosi nelle proprie case, che diventano il luogo di tutte attività;
- i soggetti più deboli, come gli anziani soli, sperimentano difficoltà di vario genere, dal malessere psicologico all’eccesiva distanza dai servizi;
- nei momenti in cui non sono a scuola, i bambini possono incontrare i propri coetanei per studiare, giocare o fare sport solo se accompagnati presso le loro case;
- in molti casi i servizi accessibili direttamente da un edificio o un isolato non corrispondono alle esigenze concrete degli abitanti, che sono costretti a percorrere tragitti più o meno lunghi per raggiungere i servizi di reale interesse;
- gli spostamenti verso i luoghi in cui i servizi sono accessibili comportano spreco di tempo e risorse.
Le iniziative che propongono forme solidali di coabitazione, o cohousing, puntano a ricomporre il tessuto dei quartieri mettendo in comune tra gruppi di vicini (cohouser) le aree, coperte o scoperte, in cui svolgere le attività comuni: si va dai parchi giochi alle lavanderie, dagli asili nido ai laboratori e alle mense.
Nel cohousing le energie (intese anche in senso più ampio, come investimento di denaro) vengono convogliate verso progetti che, pur riconoscendo la singolarità delle abitazioni di chi partecipa, prevedono spazi di servizio condivisi.
Qual è la storia del cohousing?
Il primo esempio documentato di cohousing risale al 1964 ed è stato realizzato dall’architetto danese Jan Gudmand-Hoyer. Nei decenni successivi, con un crescendo di interesse verso questa forma di coabitazione solidale, il fenomeno si è diffuso in tutta la penisola scandinava, per attecchire in seguito negli Stati Uniti (anni ’70) e in Gran Bretagna (anni ’90).
Non sorprende che l’idea di comunità abitativa, definita aggregando un insieme di case intorno a nuclei costituiti dagli spazi per i servizi e le attività comuni, sia nata in Danimarca, vista la lunga tradizione di politiche sociali e sensibilità verso le scelte sostenibili – prima ancora che il termine diventasse di tendenza.
Con una riflessione analoga, possiamo comprendere anche l’affermazione del cohousing negli USA durante il periodo ancora connotato dalla visione hippy della comune e del rapporto con la natura. Tra le aree poste in condivisione nella coabitazione solidale, infatti, mantengono una certa prevalenza le aree verdi scoperte, sistemate come parco oppure offerte ai singoli nuclei familiari per la coltivazione di orti.
Oggi, progetti di cohousing sono stati portati a termine o sono ancora in fase di realizzazione in tutto il mondo, Italia compresa.
Quali sono le regole del cohousing?
La lontana parentela con la filosofia dei figli dei fiori e con altre concezioni solidali della vita comunitaria non deve creare fraintendimenti riguardo al cohousing, che si colloca piuttosto nell’ambito (ampio e articolato) della progettazione partecipata.
I cohouser decidono di mettere in relazione i propri alloggi, dotandoli, in base a specifiche esigenze, dei servizi condivisi necessari, localizzati all’interno di edifici o in spazi aperti: si realizza quindi una forma di vicinato “attiva”, nella quale i proprietari delle unità immobiliari si accettano reciprocamente e scelgono quali aree impiegare in comune.
I progetti di cohousing includono di solito gruppi di massimo 40 unità abitative e possono riguardare:
- strutture preesistenti o costruzioni ex novo.
In entrambi i casi, i soggetti interessati a realizzare la coabitazione solidale devono interagire con i progettisti, fornendo indicazioni sulle esigenze che lo schema finale dovrà soddisfare e chiarendo quali funzioni non potranno essere tralasciate.
Secondo il metodo della progettazione partecipata, il dialogo tra il gruppo degli aspiranti cohouser e i professionisti chiamati a delineare l’intervento di cohousing deve essere “moderato” da uno o più facilitatori, cioè da mediatori esperti, in grado di:
- lavorare separatamente con il gruppo, facendo emergere tutte le necessità e le istanze fondamentali per la creazione del nuovo esperimento di vicinato;
- aiutare gli aspiranti cohouser a illustrare le proprie esigenze ai progettisti;
- gestire l’incontro / scontro fra tesi emerse nell’ambito del gruppo ed eventuali obiezioni avanzate dai tecnici.
Di conseguenza, riferendosi ai promotori dell’intervento come a un cliente unico, il progettista potrà applicare la propria visione per suggerire le soluzioni più adatte al contesto, tenendo conto degli input ricevuti con la mediazione del facilitatore.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del cohousing?
In generale, il cohousing tende a realizzare i seguenti obiettivi:
- condividere le risorse;
- garantire sostenibilità;
- evitare gli sprechi.
La condivisione delle risorse di spazio destinato alle attività comuni rappresenta un grosso beneficio per i cohouser, che, oltre al vantaggio di interagire con gli altri vicini, ottengono un risparmio sulle spese di gestione.
Per esempio, nel caso il progetto di cohousing includa una palestra, i vari proprietari delle unità abitative incluse nella coabitazione solidale potranno praticare sport senza versare quote di abbonamento aggiuntive, ma condividendo il pagamento periodico delle pulizie e, in caso di necessità, il costo sporadico delle riparazioni.
Per gli anziani, l’uso condiviso delle attrezzature con altri cohouser, specialmente se coetanei, costituisce uno strumento efficace per combattere l’isolamento e trovare nuovi interessi. Alcuni progetti di cohousing nascono proprio per venire incontro alle particolari necessità di gruppi di persone in età avanzata, soli o in coppia, che aspirano ad essere circondati da un vicinato affine innanzitutto per età.
Rendendo superflui gli spostamenti fuori dal quartiere, si evitano gli sprechi e si contribuisce a rendere tutto il sistema più sostenibile.
In un certo senso, gli svantaggi del cohousing derivano dalle stesse caratteristiche a partire dalle quali si definiscono i vantaggi. La condivisione può trasformarsi in un’arma a doppio taglio, qualora nel tempo si comprenda di non essere pronti a rinunciare a parte della propria privacy: se non siamo predisposti alla vita in comunità, il cohousing potrebbe non rappresentare la scelta più indovinata.
I problemi possono determinarsi a causa di cambiamenti imprevisti nel comportamento dei vicini/cohouser. Il rifiuto di condividere le spese o il mancato rispetto delle regole fissate per l’uso degli spazi comuni, scoraggeranno anche il sostenitore più ottimista della coabitazione solidale.
Foto di Zac Gudakov su Unsplash